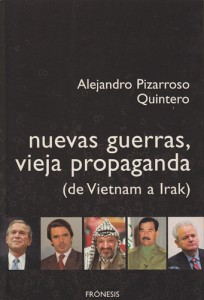Nuevas guerras, vieja propaganda (de Vietnam a Irak)
Nuevas guerras, vieja propaganda (de Vietnam a Irak), di Alejandro Pizarroso Quintero, Cátedra-Madrid, 2005Questa non può essere una normale introduzione. Non può essere né un’analisi critica né un garbato e convincente invito alla lettura. Per due ragioni.
La prima è che il libro di Alejandro Pizarroso, ormai affermatosi come uno dei maggiori studiosi in Europa di comunicazione e propaganda in tempo di guerra, non ne ha davvero alcun bisogno. Ne parlerò dunque assai poco: basti per intanto sottolinearne la rigorosa prospettiva storiografica (coraggiosamente applicata a una materia viva, e dunque in rapida evoluzione), la lucidità investigativa, l’abbondanza di dati e di apparati cronologici.
La seconda è che sono io stesso, giornalista, inviato speciale, corrispondente di guerra, la cavia impietosamente sezionata: il protagonista, la comparsa, lo spettatore degli eventi che queste pagine ripercorrono; il complice e al tempo stesso la vittima dell’insaziabile Moloch dell’informazione globalizzata.
E’ un ruolo difficile, spesso ingrato, che l’Autore pone giustamente al centro della sua inchiesta sulla propaganda, intesa non solo come “necessità di ottenere l’appoggio della propria retroguardia manipolando la propria opinione pubblica”, ma anche come arma che, proiettando i conflitti attraverso i media, è in grado di influenzare e “modificare la percezione di altre opinioni pubbliche non direttamente coinvolte e quella dell’avversario”.
Già da questa osservazione programmatica, contenuta nel capitolo iniziale, s’intuisce la complessità dell’opera qui intrapresa da Pizarroso (e del mestiere che ho scelto di fare). I capitoli successivi sono la puntuale, dettagliata dimostrazione di quell’assunto, in un serrato alternarsi di fatti, documenti, indagini massmediologiche che fotografano mezzo secolo di guerre e di menzogne, di informazione e di disinformazione: dal Vietnam all’irruzione del terrorismo islamico. Accompagnano il lettore nei meandri più oscuri e controversi dell’odierno sistema delle comunicazioni e ne descrivono i profondi cambiamenti e la progressiva sofisticazione: nuovi conflitti, nuovi media, nuovi strumenti di propaganda.
Da più di 25 anni mi occupo di guerre e di guerriglie: credo di averle seguite tutte, dal Libano in poi. Molti mi chiedono perché. Lascio la risposta all’Autore: “La guerra è probabilmente l’attività più ripugnante a cui gli esseri umani possano dedicarsi. Ma proprio perché mette in gioco il tutto per tutto, è anche un’attività affascinante”. Il motivo fondamentale è però un altro. E Pizarroso lo spiega con assoluta chiarezza: “Conoscere le guerre, studiarle, non significa accettarle. Al contrario, è il primo passo per contribuire a limitarle, per farle sparire dalla faccia della terra”. Sottoscrivo ogni parola: se il mio lavoro di corrispondente e di testimone dei tempi ha ancora un senso, è tutto e soltanto in queste due righe.
Ho dovuto guardarmi dalla disinformazione e dalla propaganda fin dall’inizio della mia professione. E credo di averne conosciuto tutti i variegati aspetti, i metodi e le manifestazioni, dalle più rozze alle più moderne e sofisticate. I miei primi servizi furono in Medio Oriente e in Africa, all’inizio degli anni Ottanta: l’assassinio del presidente egiziano Anwar Sadat, l’invasione israeliana del Libano, la guerra in Eritrea, la lotta del Frente Polisario. Allora, e soprattutto in quei paesi, i mezzi di cui noi giornalisti disponevamo erano scarsi. I computer, e tanto meno internet, non esistevano; i sistemi di comunicazione erano inesistenti e solo nelle grandi città era possibile trovare un telefono funzionante o un telex da cui inviare un pezzo o ricevere qualche informazione; i giornali e le tv locali erano zeppi di balle di regime, di comunicati ministeriali o di proclami delle fazioni in guerra. L’unica possibilità di verificare le notizie, di apprendere con certezza gli sviluppi di una crisi politica o di un’azione militare, di avere la conferma di un colpo di stato o dell’esito di un’importante riunione di governo era il World Service della BBC: la mitica, sempre attendibile, sempre puntuale Radio Londra.
Cercavamo di procurarci i migliori modelli di radioline Sony a onde corte, piccoli, precisi, con antennine estensibili e potenziabili. Erano il nostro ancoraggio al mondo e l’unica fonte autorevole di informazioni indipendenti, oltre a quelle che potevamo procurarci localmente.
Del resto a noi inviati non si richiedeva che di scrivere ciò che vedevamo (regola alla quale io continuo ad attenermi) e di scovare, se ne eravamo capaci, “qualche straccio di notizia”. Si era ancora nell’epoca del giornalismo artigianale e un po’ romantico: penna e taccuino per noi della carta stampata; lunghi tempi di trasmissione e di montaggio per i colleghi delle tv. La CNN era appena nata, ma ci sarebbe voluto un decennio prima che, con l’avvento dei computer e di internet, rivoluzionasse il sistema dell’informazione. Insieme a quello della disinformazione e della propaganda.
Il punto di svolta fu la guerra del Golfo del 1991. Era dai tempi del Vietnam che gli Stati Uniti non dispiegavano un simile impegno militare in un conflitto di teatro che prevedeva complesse operazioni aeronavali e terrestri, con un inevitabile funesto corollario di K.I.A, M.I.A., “friendly fire” e “collateral demage”. La sindrome vietnamita, simboleggiata dalle immagini dei body bags, doveva essere scongiurata a ogni costo. Tanto più che, negli ultimi cinque o sei anni, il sistema dell’informazione aveva subito mutamenti epocali. La rivoluzione tecnologica si era ormai consumata anche nel mondo della comunicazione: l’intuizione di Ted Turner si era trasformata nella realtà della tv globale, nelle news in tempo reale, 24 ore su 24.
I comandi americani erano certamente consapevoli che l’informazione, assai più che nelle guerre del passato, avrebbe influenzato in modo decisivo l’opinione pubblica, all’interno come all’esterno degli Usa: solo un largo consenso popolare aveva permesso a George Bush padre di assemblare la forza multinazionale contro Saddam Hussein.
Shimon Peres, riferendosi al conflitto in Medio Oriente, colse appieno il senso del cambiamento in atto quando, in un’intervista, affermò: “Oggi quello che raccontano i media è più forte di ciò che avviene realmente sul campo di battaglia. E’ un dato fondamentale: le immagini e le informazioni diffuse a flusso continuo rendono molto difficile il controllo delle emozioni e delle reazioni dei due popoli che si fronteggiano”. In sintesi: nelle guerre contemporanee l’informazione non è più soltanto una delle armi a disposizione degli opposti schieramenti. E’ diventata l’arma per eccellenza, la vera bomba atomica della nostra epoca.
Si sa che i militari e l’intelligence, fin dai tempi di Alessandro Magno, che al seguito dei suoi eserciti manteneva schiere di cronisti e di annalisti, hanno sempre cercato, con scarso successo, di addomesticare i media. Nel 1991, durante l’operazione Desert Storm, fecero di tutto per controllarli e tenerli all’oscuro di ciò che realmente avveniva sul terreno.
In Arabia Saudita il Pentagono aveva arruolato centinaia di addetti alle comunicazioni e di agenti dei servizi di sicurezza militari al solo scopo di tenere a bada un migliaio di giornalisti che campeggiavano in un albergo di Daharan. Il Jib, Joint information bureau, pretendeva di essere la sola fonte autorizzata di informazioni e aveva imposto a tutti i corrispondenti di sottoscrivere una serie di “ground rules” che imponevano a tutti i reporter di non allontanarsi dalla città di Daharan, 600 chilometri a sud della linea del fronte, pena il ritiro dell’accredito e l’immediato rimpatrio. Ogni richiesta di intervista o di visita nelle basi aeree doveva essere preceduta da una domanda scritta cui seguivano giorni di attesa. I pochi giornalisti inclusi nei “combat pools” venivano trasportati in elicottero per visite guidate in luoghi di scarsissimo interesse. Era, di fatto, una forma di censura che mirava a impedire il libero accesso alle zone operative. Ma non fu del tutto efficace.
Io per esempio, con alcuni altri colleghi, mi rifiutai di accettare queste assurde regole. Affittai una jeep, feci provviste di acqua, cibo e benzina e di notte, a fari spenti, imboccai una pista nel deserto riuscendo ad aggirare i check point americani: nelle settimane successive potei finalmente lavorare al fronte, dove fui sempre accolto con grande cordialità dai militari (americani, inglesi, francesi, kuwaitiani, siriani, sauditi). Dormivo con loro nelle tende, osservavo le manovre dei tank, potei assistere allo sfondamento delle linee irachene e vedere le trincee e i pozzi incendiati, riuscendo infine ad arrivare a Kuwait City con i primi mezzi corazzati e a raggiungere Bassora durante la rivolta degli sciiti. Qui fui fatto prigioniero dagli iracheni e trattenuto per una settimana prima di essere trasportato in elicottero a Baghdad e consegnato alla Croce rossa. Un’esperienza che non rimpiango affatto, perché mi diede l’opportunità di vedere quella guerra anche con gli occhi dei soldati di Saddam Hussein, dalla parte degli sconfitti.
La mia percezione di quella guerra, e dunque le mie valutazioni e le mie analisi, sarebbero state del tutto diverse se mi fossi attenuto alle famigerate “ground rules” del Pentagono, limitandomi a riferire le vaghe, incomplete e sempre ottimistiche informazioni centellinate dai comandi militari nel corso dei quotidiani briefing per la stampa.
Disinformazione e propaganda furono utilizzate a piene mani da entrambi i contendenti, prima, durante e dopo il conflitto. La falsificazione più clamorosa fu senza dubbio la pretesa pericolosità dell’esercito di Saddam, definito “il quinto del mondo”. Nelle settimane che precedettero l’attacco i media fecero a gara nell’ingigantire la “minaccia irachena alla stabilità e alla pace nella regione”, nel descrivere con dovizia di dettagli il potente arsenale di Baghdad, dotato di missili a lungo raggio, testate chimiche, batterie antiaeree, bunker a prova di atomica e infinite divisioni corazzate “decise a battersi fino all’ultimo uomo”. In realtà, fu subito evidente che l’esercito di Saddam non avrebbe potuto offrire alcuna seria resistenza alla soverchiante forza e superiorità tecnologica della coalizione; e che la lunga campagna aerea fu una specie di tiro al bersaglio, un’esercitazione che permise di sperimentare “dal vivo” e in quasi assoluta sicurezza le nuove armi a disposizione di Washington: dalle bombe intelligenti agli strumenti per la visione notturna, dai proiettili all’uranio impoverito ai missili Cruise, dai bombardieri invisibili F-117 Stealth all’elettronica avanzata degli aerei radar Awacs.
Quando entrai in Kuwait con la prima colonna dei blindati, sul fronte di Hafr al-Batin, dalle trincee irachene uscirono gruppi di soldati con le mani alzate in segno di resa: molti erano scalzi, da giorni non mangiavano altro che datteri secchi e il loro armamento consisteva in vecchi fucili AK-47, alcune mitragliatrici arrugginite e qualche cassa di munizioni. Chiedevano soprattutto acqua da bere.
Ebbi anche modo di osservare l’impatto dei proiettili all’uranio sulle carcasse dei tank iracheni. Un foro d’ingresso di 15-20 centimetri, la spessa corazza d’acciaio trapassata come fosse di burro, e all’interno un impasto vetrificato di cavi, ossa, brandelli di divise, amperometri, capelli, mandibole, orologi fusi come in un quadro di Salvador Dalì. Passarono anni prima che si cominciasse a parlare di “sindrome del Golfo” e degli effetti a lungo termine – sui militari della coalizione, ma soprattutto sulla popolazione civile irachena – della contaminazione radioattiva provocata dai proiettili all’uranio impoverito, dell’insolito incremento delle leucemie e dei tumori, degli aborti, delle malformazioni genetiche dei neonati.
Negli anni Novanta abbiamo assistito a un ulteriore salto di qualità. Internet e l’informazione online si sono universalmente imposti, determinando profonde modificazioni nel mondo della comunicazione e sucitando nuove problematiche. La ricerca delle fonti, per esempio, è enormemente facilitata dall’accesso in rete. Ma chi può garantire la loro credibilità? Come orientarsi nel flusso ininterrotto di dati e informazioni contraddittorie? Non sempre le menzogne, come nel caso della rozza propaganda irachena, sono facili da smascherare. Si annidano nelle false notizie, nei “rumors” di strada, nella valanga di dichiarazioni, cifre, grafici, scenari, indiscrezioni che internet rovescia senza sosta sul video del nostro lap top alimentando l’illusione di una realtà sotto controllo, di una verità a portata di mouse, documentata in tempo reale.
Le nuove tecnologie sono di grande aiuto. Non rimpiango di certo la lentezza della macchina da scrivere, l’angoscia della fila al telex con la deadline del giornale che si avvicina o la linea internazionale che cade mentre stai dettando il pezzo dall’unica cabina telefonica disponibile. Sono grato alla leggerezza, alla straordinaria velocità e versatilità del mio lap top. E alla tecnologia satellitare che mi consente di avere accesso immediato a tutte le agenzie di stampa, di consultare gli archivi di tutti i giornali del mondo e di trasmettere il mio articolo in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, anche in mezzo al deserto, in pochi secondi. Ma tutto ciò non ci difende dalle trappole della disinformazione e della propaganda. Al contrario, ne accresce la frequenza e la rende più insidiosa.
E’ cambiata anche la funzione dell’inviato di guerra. Il racconto di prima mano, la testimonianza diretta, non sono più sufficienti. Al giornalista “globalizzato” si richiedono ormai con sempre maggiore insistenza valutazioni specifiche di ordine politico, strategico, persino militare. La cronaca lascia il posto all’analisi, al giudizio morale, al commento. Personalmente, mi sottometto di malavoglia a simili esigenze editoriali. Preferisco restare fedele alla frase che Graham Greene mette in bocca al protagonista di The Quiet American: “Sono un reporter; Dio esiste soltanto per quelli che scrivono gli articoli di fondo”.
Gli anni Novanta hanno visto mutare profondamente il quadro internazionale. Il crollo dell’Impero sovietico e del muro di Berlino hanno posto fine alla guerra fredda e alla vecchia divisione tra le sfere d’influenza dei due blocchi, fonte di ripetute crisi e di conflitti locali: soprattutto in Africa, dove la dissoluzione degli stati ha esasperato le tensioni etniche, allargato le maglie dell’illegalità e alimentato guerriglie non ideologiche, che si autofinanziano con il traffico di armi e di droga, con il commercio clandestino di oro e di diamanti.
Ai conflitti di tipo convenzionale si sono gradualmente sostituite forme violente di confronto armato che non è sempre facile prevedere o catalogare con gli schemi consueti: spinte irredentiste e secessioniste, rivolte a sfondo economico o religioso, rivendicazioni politiche o territoriali. Nello scenario dinamico seguito al relativo immobilismo della guerra fredda hanno assunto un ruolo di primo piano gli organismi multilaterali e le entità sovranazionali: Nato, Onu, Unione europea. Il consenso dell’opinione pubblica prima e durante qualsiasi azione militare è diventato non soltanto necessario, ma è ormai una pre-condizione ineludibile.
A questo proposito sono emblematiche le vicende della Somalia e del Rwanda. L’operazione Restore Hope nell’ex colonia italiana del Corno d’Africa, lanciata nel 1992 dagli Stati Uniti e da una nutrita schiera di paesi alleati, fu quasi “imposta” dai mass media. Nel caos di una guerra civile innescata dal crollo del regine di Siad Barre, le immagini drammatiche delle vittime della carneficina e dei bambini condannati a morte per fame suscitarono un’ondata di sdegno e di compassione. L’Occidente, ricco, opulento e reduce dalla vittoriosa campagna irachena, non poteva restare indifferente.
L’“intervento umanitario” in Somalia fu anche l’occasione per fare un po’ di marketing, mostrando i valorosi soldati che distribuiscono acqua e cibo alle popolazioni bisognose, allestiscono ospedali da campo, ristabiliscono pace e sicurezza. Lo sbarco dei marines sulla spiaggia di Mogadiscio fu organizzato come la scena di un film di John Wayne. Alle troupe televisive fu comunicato il luogo esatto dell’azione e sprattutto l’ora, che doveva coincidere con il “prime time” negli Stati Uniti, il picco del massimo ascolto. Quando i mezzi anfibi rovesciarono sulla spiaggia il primo contingente, i militari – spaesati e appesantiti da un’assurda mole di bagaglio – si trovarono di fronte un muro di telecamere e di riflettori. E una folla di ragazzini somali che si rotolava dalle risate.
C’era, in realtà, assai poco da ridere. Come spiega l’Autore nel capitolo dedicato alla Somalia, la missione di pace si trasformò in poco tempo in un intervento armato dalle incerte finalità, irrimediabilmente votato al fallimento da una serie di errori di valutazione politica e militare e di dissidi tra i vari contingenti. Ma il punto che mi preme qui sottolineare è l’episodio decisivo dell’abbattimento dei due elicotteri Black Hawk nell’ottobre 1993, non a caso sceneggiato anni dopo in un film hollywoodiano di successo: l’uccisione dei soldati americani, ma più ancora l’immagine simbolica dei due elicotteri fracassati al suolo e circondati da una moltitudine inferocita, segnò la fine del consenso a quella missione, decretandone l’inevitabile disfatta.
La convinzione che, dopo la Somalia, fosse impossibile ottenere il consenso dell’opinione pubblica a un altro intervento sul continente africano, fu una delle ragioni – certamente non la sola – che paralizzarono per mesi l’Onu e la comunità internazionale di fronte al genocidio in Rwanda. Senza voler giustificare la colpevole indifferenza dell’Occidente, si può capire la riluttanza di Bill Clinton nei confronti di un impegno militare che la “sindrome di Mogadiscio” rendeva quanto meno assai rischioso. E proprio nel momento in cui si surriscaldavano altri fronti, ben più vicini, anche dal punto di vista geografico, agli “interessi vitali” degli Stati Uniti e dell’Europa: la Bosnia, la Serbia, la Croazia, il Kosovo, l’intera regione balcanica sull’orlo del baratro. E la faticosa ricerca di una “road map” per la tormentata Palestina.
A dieci anni da Desert Storm, gli attentati dell’11 settembre 2001 a New York e a Washington segnalano – dopo il crollo del muro di Berlino – un secondo rivolgimento epocale, dal punto di vista geostrategico come nel campo dell’informazione e della propaganda.
Per alcuni mesi l’onda emotiva del clamoroso attacco terroristico anestetizzò la stampa, non solo quella americana, che nel periodo immediatamente successivo agli attentati sembrò quasi abdicare alla sua primaria funzione di controllo e di denuncia. Inauditi e ingiustificati episodi di violenza e repressione, in Palestina come in Cecenia, furono compiuti in nome della lotta al terrorismo. Mentre al Pentagono il sottosegretario alla Difesa Paul Wolfowitz metteva a punto la nuova strategia mediatica della Casa Bianca.
Con un budget straordinario e la direzione affidata al generale dell’aviazione Simon Warden, fu istituito l’Office of Strategic Influence, che aveva il compito di influenzare l’opinione pubblica dei paesi alleati e degli “stati canaglia” e di dimostrare con ogni mezzo, anche con la diffusione di notizie false, l’esistenza di prove che potessero giustificare un attacco preventivo contro l’Iraq. Le operazioni contro i taliban in Afghanistan, al contrario, non avevano bisogno di alcun particolare supporto mediatico: per il semplice fatto che l’opinione pubblica considerava questo intervento legittimo (approvato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite) e giustificato (dall’esplicita protezione accordata dal regime di Kabul a Bin Laden e ai suoi legionari arabi).
Il caso iracheno era totalmente diverso. E richiedeva un massiccio impegno propagandistico. Il primo assioma da dimostrare era l’inverosimile “link” tra Saddam Hussein (dittatore laico, social-baathista e nazionalista) e Osama (fervente religioso, wahhabita e panislamico). L’Ufficio di Wolfowitz s’inventò la storiella – ripresa da tutti i maggiori organi di stampa – del presunto incontro di Mohammed Atta, capo dei dirottatori dell’11 settembre, con emissari di Saddam nei locali dell’ambasciata irachena a Praga: era la “prova schiacciante” del legame tra Baghdad e i terroristi di al-Qaeda. Toccò all’allora presidente ceco Vaclav Havel, dopo approfondite indagini dei servizi di sicurezza, notificare alla Casa Bianca che quell’incontro non era mai avvenuto. La smentita fu pubblicata alla fine di ottobre del 2002 sull’Herald Tribune, accanto a un imbarazzato articolo nel quale si sosteneva che la Cia addossava la responsabilità della falsa notizia a un ignoto “informatore”.
Il secondo dogma da conculcare a ogni costo era la pericolosità del regime iracheno e del suo mirabolante arsenale di WMD, weapons of mass destruction. Dopo la pubblicazione, nel 2002, del libro-intervista dell’ex ispettore dell’Onu Scott Ritter (War on Iraq: what team Bush doesn’t want you to know), che dimostrava in modo inoppugnabile come la quasi totalità dell’armamento chimico e biologico iracheno fosse stato eliminato dopo il 1991, solo Bush e Tony Blair continuarono a fingere di credere che l’Iraq possedesse armi di distruzioni di massa. Ma solo di recente lo stesso Wolfowitz ha riconosciuto che si trattava di “un pretesto” per convincere gli alleati europei recalcitranti a partecipare all’offensiva militare.
A Baghdad si sorrideva degli “scoop” e delle “fughe di notizie” propalate dalla Casa Bianca. Il giorno del mio arrivo nella capitale irachena, il 5 febbraio 2003, lasciati i bagagli all’Hotel Rashid mi precipitai alla conferenza stampa organizzata per sbeffeggiare l’intervento di Colin Powell alle Nazioni Unite, conclusosi poche ore prima con la presentazione delle “prove” contro il regime di Saddam. “Ecco finalmente le nostre armi di distruzione di massa” stava dicendo il portavoce del governo additando il fermo-immmagine del segretario di Stato che brandiva una provetta con una polverina bianca. “Sono al Palazzo di vetro!” L’indomani fummo trasportati in auto in una base militare non lontano da Fallujah: il sito che Powell, sulla scorta di alcune foto satellitari, aveva indicato come probabile rampa di lancio per missili con testate chimiche e biologiche non era altro che un centro di sperimentazione per i motori dei razzi al-Samud. Gli ispettori dell’Onu l’avevano appena visitato, senza rilevare anomalie.
Ciò nonostante, l’amministrazione Bush riuscì nel suo intento: convincere i media e l’opinione pubblica (soprattutto americana) che Saddam rappresentava un pericolo reale e imminente per l'Occidente, che il suo rovesciamento era una priorità assoluta e che per conseguirlo si doveva ricorrere a un intervento armato. Rendendo accettabile il principio, giuridicamente insostenibile e politicamente pericoloso, della “guerra preventiva”.
Nel 1991, durante la guerra del Golfo, i grandi network televisivi e le associazioni dei giornalisti americani avevano duramente protestato contro l’avvilente e inefficace sistema dei “combat pools”. Nel 2003 Casa Bianca e Pentagono adottarono una nuova politica mediatica: l’inclusione (“embedding”) di un ristretto numero di reporter autorizzati nelle unità operative sul campo di battaglia.
L’”embedding” ha indubbiamente rappresentato un passo in avanti: questa volta in Iraq è stato possibile osservare l’azione sul terreno e seguire le truppe in combattimento. Ma restano molti fattori limitativi della libertà dei giornalisti: una volta “embedded” il giornalista è tenuto a comportarsi come un soldato, a ubbidire agli ordini degli ufficiali, a limitare i propri movimenti e a sottomettere i propri articoli, foto o filmati al controllo della censura militare.
A Baghdad dovevamo affrontare analoghi problemi. Ma almeno, adottando qualche stratagemma, potevamo tentare di sfuggire ai controlli e parlare con la gente nelle strade. Io parlo l’arabo ed ero facilitato nei contatti con la popolazione. Lavoravo spesso di notte, quando riuscivo a liberarmi dei segugi del ministero dell’Informazione, riuscendo a intervistare medici, leader religiosi, professionisti. Fingendomi interessato ai siti archeologici e alle opere d’arte islamica sono riuscito a viaggiare fino a Kirkuk e a Mosul, nel nord, e a sud fino a Bassora e alle città sante sciite di Kerbala e Najaf. Per due volte sono stato colto in fallo e ho dovuto pagare ingenti somme per riavere la press card.
A ogni giornalista era stato assegnato un “minder”: un “interprete” che ci seguiva ovunque e che riferiva tutte le nostre mosse ai servizi di sicurezza. Dovevamo ottenere permessi scritti per uscire dalla città, per visitare gli ospedali e le istituzioni pubbliche, per intervistare funzionari del governo, intellettuali, medici o semplici cittadini. La conseguenza immediata, se non si rispettavano queste regole, era l’espulsione dal Paese. Eravamo costantemente ricattati, anche dal punto di vista finanziario: ogni giornalista doveva versare 100 dollari al giorno per l’uso del proprio telefono satellitare, altri 100 per il “minder” e 30 in dinari per imprecisati “servizi generali” (era in realtà il bakshish per gli impiegati del centro stampa). Le tv pagavano più del doppio. Non potevamo avvicinarci alle “zone sensibili”, alle basi militari, alle sedi del partito o della polizia, ai palazzi presidenziali.
Con l’inizio dei bombardamenti la situazione peggiorò notevolmente. Le uniche escursioni autorizzate fuori dall’albergo dei giornalisti, per “vedere i civili massacrati dagli americani”, avvenivano su autobus scortati ed erano seguite dalle surreali conferenze stampa di Mohammed Saeed al-Sahaf, “MSS”, il grottesco ministro dell’Informazione iracheno, diventato un personaggio cult in virtù delle panzane che sparava in diretta sui network di tutto il mondo. Bastava però guardare le scarpe dei feriti per accorgersi che non si trattava di civili. E che alcuni dei “selvaggi bombardamenti americani”, come quello del mercato di Shu’ala, erano in realtà il risultato di qualche missile antiaereo iracheno caduto tra la gente: era sufficiente misurare l’ampiezza del cratere nel suolo.
La stessa attenzione era ovviamente necessaria per valutare le notizie diffuse dal comando americano che leggevamo su internet: di nascosto, perché gli iracheni ci proibivano di usare il satellitare in albergo. Dopo la caduta di Saddam cominciammo infine a muoverci liberamente, ma non senza rischi e difficoltà: gli americani non hanno mai facilitato il compito dei cronisti. Per non parlare dei numerosi “incidenti” nei quali amici e colleghi hanno perso la vita. A cominciare da Patrick Bourrat, della tv francese, che era stato prigioniero con me a Bassora nel 1991 ed è morto schiacciato da un tank americano in Kuwait, nel marzo 2003, mentre cercava di salvare l’operatore il quale non si era accorto che il mezzo militare gli stava arrivando addosso. Per finire (ma non sono stati gli ultimi caduti!) con José Couso, di Tele Cinco, e Taras Protsyuk, della Reuters: mi trovavo a pochi metri da loro, al quindicesimo piano dell’Hotel Palestine, quando furono colpiti da una granata sparata da un tank americano.
Fu proprio quel pomeriggio dell’8 aprile 2003 che vidi per l’ultima volta “MSS”, detto anche Comical Ali, Baghdad Bob, lo Shahrazade di Baghdad o anche l’Harpo Marx dell’Iraq. Una ditta del Connecticut, la Hero Builders, specializzata in pupazzi parlanti, aveva lanciato sul mercato, a 36 dollari, la “Iraqi Dis-information minister Action Figure Doll”. Un sito web dedicato “al ministro che si erge al di sopra della verità” vantava più di 4 mila contatti al secondo e includeva un “florilegio di citazioni immortali”: classici come “La mia previsione iniziale è che moriranno tutti” e “La mia sensazione è che li massacreremo”, fino al profetico “Dio arrostirà i loro stomaci all’inferno”.
Quel giorno l’ex tirapiedi di Saddam assurto al rango di star mediatica internazionale diede il meglio di sé. I tank americani erano appostati nel palazzo presidenziale sulla riva opposta del fiume, a meno di 400 metri dall’albergo. I soldati iracheni se la davano a gambe sull’argine o cercavano scampo a nuoto. Colonne di mezzi blindati avanzavano verso il centro della capitale. MSS, imperturbabile, in divisa verde oliva, basco nero e pistola alla cintura, sfoderò il consueto ghigno sarcastico e in un impeto d’ispirazione annunciò al mondo che la realtà non esiste: è solo un’illusione. “Non prestate fede alle menzogne dei mercenari anglo-americani: li abbiamo circondati e li faremo a pezzi! L’Iraq sarà la loro tomba. Io vi dico che gli infedeli si stanno suicidando a centinaia alle porte della città”.
Il suo capolavoro fu, nei primi giorni della guerra, la felliniana trovata di un inesistente pilota americano abbattuto nel cielo di Baghdad, che scatenò una frenetica caccia all’uomo sulle rive del Tigri: centinaia di iracheni, incitati dagli sgherri del partito, giuravano di averlo visto staccarsi dal paracadute e precipitare nel fiume, che fino a notte inoltrata riverberò dei fuochi appiccati per stanare la preda. E quando anche gli sciuscià che stazionavano davanti al Palestine avevano capito che la guerra era perduta, MSS si ostinava a enumerare le strepitose vittorie irachene sostenendo che “mentire è vietato in Iraq: il presidente non tollera altro che la verità”.
La verità: è questa la prima vittima di ogni guerra, il vero fronte sul quale noi giornalisti combattiamo la quotidiana battaglia per l’informazione. E il nostro nemico, purtroppo, non è il simpatico Comical Ali, la cui rozza propaganda era così facile da smascherare. L’insidia della disinformazione s’annida, invisibile, nella contraddittoria valanga di dichiarazioni, cifre, grafici, scenari, indiscrezioni che internet rovescia senza sosta sul video del nostro computer; nella progressiva concentrazione del potere mediatico, che facilita la manipolazione delle notizie, e nella commistione tra editoria e politica; nel potere subliminale del messaggio televisivo; nei ritmi sempre più veloci e sincopati dell’informazione in tempo reale, che non consentono un’accurata verifica delle fonti.
Chi scrive, ma anche chi legge, ascolta la radio o guarda la tv, deve dunque sviluppare anticorpi sempre piu efficaci.
E questo libro di Alejandro Pizarroso è un formidabile, potentissimo antidoto.
Giovanni Porzio
Milano, giugno 2005