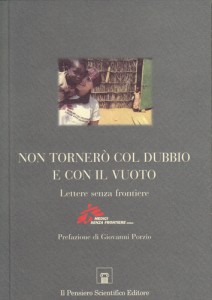Non tornerò col dubbio e con il vuoto. Lettere senza frontiere
Prefazione a Non tornerò col dubbio e con il vuoto. Lettere senza frontiere, Medici senza frontiere, Il Pensiero Scientifico Editore, 2007Va dritta alla sostanza Stella, medico che scrive dalla Repubblica Democratica del Congo: “Ecco quello che facciamo: diamo voce a tutti, il resto non sta a noi giudicarlo”. E tutti sono le prostitute sieropositive di Kinshasa a cui Stella distribuisce i farmaci antiretrovirali. Tutti sono anche “quelli che non ti ringraziano, che ti maledicono perché sei bianco e hai quello che loro non hanno, tutti significa anche quelli che domani, appena te ne sarai andato, distruggeranno e ruberanno quello che hai costruito per loro”.
Partono con questo spirito gli oltre duemila volontari della brigata internazionale di Msf. Non sono eroi e non sono missionari. Sono medici, infermieri, logisti, antropologi, contabili, psicologi, farmacisti, ingegneri, architetti, tecnici di laboratorio: professionisti consapevoli di avere imboccato una “strada alternativa”, spesso arrischiata, talvolta esaltante, sempre difficile.
Mi è capitato di incontrarli nelle situazioni più estreme e nei luoghi più sperduti: in una sala operatoria in Darfur, a Baghdad prima della loro forzata evacuazione dall’Iraq, nelle paludi malariche del sud Sudan, nel mezzo di un’epidemia di colera in Congo, sotto i tiri di mortaio a Mogadiscio, tra i baby killer nel nord dell’Uganda, nelle foreste del Kivu e della Sierra Leone.
Una volta, a Goma, ero disperato. Un uomo, uno dei 400 mila profughi che dal campo di Mugunga si erano riversati sulla strada per il Rwanda era morto tra le mie braccia e i suoi quattro figli, minuscoli uccellini denutriti, erano in fin di vita. Il burocrate delle Nazioni Unite a cui avevo chiesto aiuto si era rifiutato di caricarli sulla sua fiammante Toyota. L’unica speranza era la tenda di Msf-Spagna, a mezz’ora di cammino.
Il medico, una giovane donna scarmigliata, con il camice sporco di sangue, il viso segnato dalle notti insonni e i nervi tesi dall’adrenalina, tentava da sola di arginare l’ondata di piena: gli infermi e i moribondi crollavano esausti nella spianata di fango dov’era piantata la tenda, che ormai straripava e ansimava di gemiti. Neppure per un istante, mentre le spiegavo il caso dei miei piccoli orfani, interruppe il suo lavoro: isolava i malati più gravi, preparava la soluzione fisiologica, attaccava i sacchetti delle flebo ai rami degli arbusti, cercava la vena per inserire l’ago.
Poi d’un tratto: “Dove sono? Andiamo a prenderli. Guida tu, io non ce la faccio”.
“Come ti chiami?”
“Non è importante”.
Volevo dirle che per me sì, per me e per quei quattro bambini il suo nome era importante. Ma rispettai il suo desiderio di anonimato. Poca pubblicità, nessun protagonismo: è la filosofia, e lo scudo protettivo, dei volontari di Msf. Il grande pubblico non conosce i loro nomi, non vede i loro volti alla tv, non immagina in quali condizioni siano costretti a vivere e a operare.
In queste “lettere senza frontiere”, per la prima volta, sono loro a rivelarsi, a raccontare le ansie e i dubbi, le sfide, le vittorie, le sconfitte. Le piccole grandi storie che danno un senso alla vita. Li vediamo alle prese con il coprifuoco e con i posti di blocco, con il generatore di corrente e la latrina, con le zanzare, le inondazioni, le febbri emorragiche, le bambine stuprate. Con la paura e la solitudine, ripagate dal sorriso fiducioso della gente.
Ognuno di loro osserva la realtà con occhi diversi. Anna, infermiera, ci parla degli uomini al bazaar di Ishkashim, tra le gigantesche montagne silenziose che si spartiscono il cielo afghano, delle donne che lassù non portano il chadrì e delle complicazioni dovute al parto. Andrea, medico in Katanga, ci fa conoscere Ngongo, “il più grande calciatore d’Africa”, che a cinque anni non aveva più la forza di nutrirsi ma sognava un pallone; Andrea riesce a trovarlo (“10 dollari, lo stipendio di un mse, il costo di una piroga”) e la curva del peso di Ngongo comincia a risalire: “in caduta libera fino al 16 dicembre, il 19 aveva già guadagnato mezzo chilo, poi due chili, perché per giocare al calcio bisogna essere forti, almeno stare in piedi…”
Rosanna, ostetrica a Rutshuru, miserabile vilaggio del Congo, riflette sul proprio impegno: “Dobbiamo rivedere i nostri metodi di cura, mettere in discussione i nostri canoni medici e il nostro sapere universitario per modificare il nostro modo di lavorare: spesso tutto ciò è difettoso, pieno di limiti, ma a volte pieno di risultati, spero!!” Riccardo, chirurgo in Sierra Leone, scrive: “Ieri mi è morta una donna, la vigilia di Natale!” Ma ha strappato alla morte un ragazzo di 20 anni di nome Tambà: “Sto finendo una missione difficile dove ho lavorato da morire, dove ho operato giorno e notte, dove ho salvato decine di persone. Il prezzo di tutto questo qual è? Chi lo paga? Probabilmente io, ma ne sono felice!!”
Azaad, logista a Pibor, in Sudan, ha di fronte un bimbo che a sei mesi pesa poco più di 2 chili. Lo nutrono con il latte terapeutico, spremuto da una siringa: recupera qualche etto, ma Azaad sa che morirà in ogni modo, senza un delicato intervento per correggere la stenosi dell’esofago. “Grazie al lavoro di Msf avrà dei giorni, mesi o forse anche anni di vita in più, ma difficilmente arriverà all’età adulta. Non abbiamo quindi fatto niente di speciale, a Pibo, per lui. Abbiamo fatto solamente del nostro meglio. E io ho contribuito. Anch’io ho fatto (solo) del mio meglio”.
E’ questa consapevolezza a motivare i volontari. Sono giovani con culture diverse che provengono da tutti i paesi del mondo. Ma lo sguardo d’insieme, il “terzo occhio”, ha in tutti la stessa profondità, la stessa capacità di messa a fuoco, la stessa sensibilità percettiva. “A volte questa vita fa piangere a volte ridere ma è tutto qui, senza maschere, senza finzione” scrive Jacopo, amministratore a Kampala. “Dormire in un tukul dove piove dentro, mangiando spaghetti scotti con le mani alla maniera somala, percorrendo strade sterrate con la polvere che brucia negli occhi e nella gola, bevendo acqua che sa di cloro. Sì sì, questa è vera vita, questo è tutto vero”.
E Anna, dallo Zimbabwe: “Nessuno di noi volontari ha la pretesa di cambiare il mondo, di trasformare tutte le lacrime in sorrisi, tutte le sofferenze dell’umnità in tanti momenti di gioia. Nessuno di noi ha i mezzi e le capacità per cambiare le regole del gioco e indirizzare di nuovo la Storia. Diamo semplicemente una mano – nel modo che sentiamo più consono – a chi è meno fortunato, a chi è malato e ha bisogno; prendiamo la difesa di chi è più debole e non ha voce, rimaniamo accanto a chi è disperato e non si attende più niente dalla vita. Non siamo super eroi, offriamo solo parte delle nostre energie e del nostro tempo, e a qualcuno, qualche volta, una chance in più di sopravvivere. Ma soprattutto, crediamo che ciò che facciamo abbia ancora un senso”.
Giungono dalle trincee delle guerre dimenticate, dagli oscuri territori dove è in agguato la morte, dai sordidi recessi di un’umanità negata e vilipesa. Ma sono lettere che inneggiano alla vita e trasudano speranza. I giovani – soprattutto i giovani – le leggeranno, come me, d’un fiato.
Giovanni Porzio