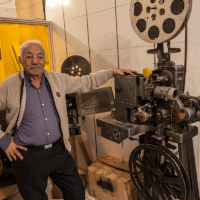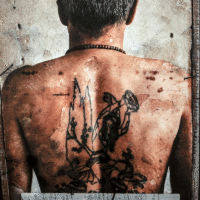The old and the new
Il “nido di spie” è oggi un museo aperto al pubblico. L’ex ambasciata americana, espugnata nel 1979 dagli studenti khomeinisti, che per 444 giorni vi tennero prigionieri decine di ostaggi, vuole essere un convincente strumento di propaganda per il regime degli ayatollah e il volontario di turno, all’ultimo semestre della facoltà di ingegneria, mi scorta in un surreale viaggio nel tempo e nelle trame ordite dal Grande Satana. Ecco le stanze blindate, i telex, i telefoni, le radio per le intercettazioni, i dispositivi per i messaggi cifrati. Ecco l’ufficio insonorizzato per i complotti top secret, il laboratorio per falsificare i passaporti, le macchine per triturare i documenti riservati e i dispacci diplomatici, in parte faticosamente riassemblati e pubblicati a spese dello stato.
C’è un solo neo: sono l’unico visitatore. E anche all’esterno, dove i muri grondano di slogan antiamericani e di sbiaditi ritratti dell’imam Khomeini, i passanti non degnano di uno sguardo il volto della Statua della libertà trasformato in un teschio assetato di sangue. A quarant’anni dalla cacciata dello scià e dall’avvento della repubblica islamica, la rivoluzione arranca: non ha saputo mantenere le promesse di riscatto sociale che l’avevano innescata, mentre il gap culturale e generazionale tra gli 80 milioni di iraniani e la vetusta teocrazia al potere continua ad allargarsi.
“Non credo più nella possibilità di un cambiamento” dice Sharmin, che traduce romanzi francesi per una casa editrice privata. “Troppe speranze tradite, troppe delusioni. Siamo stati ingannati”. La “primavera di Tehran” che nel 1997 catapultò alla presidenza il riformista Mohammed Khatami è un lontano ricordo. Il Movimento verde che nel 2009 scese in piazza contro l’elezione del populista Mahmud Ahmedinejad si è spento e la società civile osserva con crescente scetticismo i tentativi dell’attuale presidente Hassan Rouhani di arginare la crisi economica e di normalizzare le relazioni con l’occidente.
L’accordo sul programma nucleare iraniano raggiunto nel 2015, fortemente voluto e negoziato da Rouhani, aveva suscitato grandi aspettative: fine dell’isolamento, apertura del mercato, pioggia di capitali esteri. La parziale abolizione dell’embargo ha in effetti spinto l’esportazione di greggio a oltre 2,3 milioni di barili al giorno, con una ricaduta positiva sul pil, che registra un tasso di crescita del 4,5 per cento: il più elevato tra i Paesi del Medio Oriente e del Nordafrica. L’Italia, prima in Europa, ha aperto con l’Iran una linea di credito garantita di cinque miliardi di euro per promuovere progetti di sviluppo industriale. Ma con Donald Trump alla Casa Bianca, e con il prezzo del greggio solo in timida ripresa, gli entusiasmi si sono smorzati. Le banche straniere trattengono i petrodollari iraniani ed esitano a ristabilire i rapporti finanziari. Gli investitori latitano. L’alleggerimento delle sanzioni non si traduce in benefici immediati. E mentre tra Tehran e Washington è tornato il gelo, gli oppositori del governo rialzano la testa.
“Cos’ha ottenuto Rouhani in cambio dell’accordo?” si chiede Foad Izadi, analista politico di orientamento conservatore. “Niente. Noi rispettiamo gli impegni sottoscritti e Trump li rimette in discussione: è inaccettabile. Anche l’Europa è in difficoltà: deve decidere se tenere fede al trattato o figurare come il fantoccio degli Stati Uniti”.
La taghieh è l’arte tutta persiana e sciita della dissimulazione: quasi nulla, in Iran, è come appare. La semplicistica contrapposizione tra conservatori e riformatori, con la Guida Suprema Ali Khamenei arbitro assoluto della politica e della morale, non rispecchia in alcun modo la complessità e le contraddizioni della società iraniana. All’interno dei diversi schieramenti si articolano infatti interessi e strategie riconducibili a molteplici centri di potere: i militari, il clero, il parlamento, il bazaar, le fondazioni islamiche, il capitale privato. Ed è in questa chiave che vanno decifrate le manifestazioni di protesta dello scorso dicembre.
La scintilla, l’aumento del 40 per cento del prezzo delle uova, è stata accesa nella città “martire” di Mashad, dove riposano le spoglie dell’ottavo imam Reza; è rimbalzata a Qom, il “Vaticano sciita”, sede delle più importanti università islamiche del Paese, e ha propagato il fuoco in decine di città e villaggi di provincia. A Mashad, roccaforte degli avversari di Rouhani (Ebrahim Raisi, il candidato sconfitto alle presidenziali dello scorso maggio, e suo suocero l’ayatollah Ahmad Alamolhoda, esponente di spicco del clero tradizionalista), i dimostranti gridavano slogan contro il carovita e la politica economica del governo. Ma nei giorni seguenti la protesta si è spontaneamente trasformata in un boomerang per l’ala dura del regime.
La contestazione ha investito la politica estera iraniana e il coinvolgimento militare in Siria, Libano, Yemen e Iraq: un impegno che sottrae decine di miliardi di dollari alle casse dello stato. Nel mirino sono poi finiti i pilastri stessi della Repubblica islamica: i Pasdaran, i Basiji, il clero e persino il Rahbar enghelab, la Guida della rivoluzione. La posta in gioco, alimentata dagli scriteriati twitter di Donald Trump, era troppo alta per lasciarla sul tavolo. La polizia è intervenuta: quattromila arresti e una ventina di morti.
La rivolta di dicembre ha catalizzato il malcontento degli strati sociali penalizzati dall’inflazione e da una disoccupazione giovanile che sfiora il 40 per cento. Ma ha radici più profonde e strutturali. I primi a scendere in piazza a Mashad sono stati i piccoli risparmiatori ridotti sul lastrico dal fallimento di un istituto di credito che prometteva interessi doppi rispetto a quelli fissati dalle banche. Milioni di lavoratori, operai e impiegati, hanno visto svanire i loro depositi, inghiottiti dalle settemila finanziarie nate sotto l’egida di Ahmedinejad: gestite da imprenditori incompetenti legati alle Fondazioni religiose e ai Pasdaran, sono sprofondate una dopo l’altra nella bancarotta.
Rouhani è corso ai ripari imponendo un tetto del 15 per cento ai tassi d’interesse degli istituti di credito. E – soprattutto – ha cominciato a scalfire i privilegi delle più ricche e potenti organizzazioni del Paese: le Bonyad e le Guardie della Rivoluzione.
Le Fondazioni, create per incamerare i beni dello scià, controllano il 30 per cento dell’economia, non pagano tasse, non pubblicano i bilanci e rispondono direttamente alla Guida suprema. La Bonyad Mostazafan, la Fondazione degli oppressi, ha un fatturato di 12 miliardi di dollari e 700 mila dipendenti, vanta ottocento società con ramificazioni nelle banche, negli appalti per le grandi opere, nell’industria tessile, chimica, alimentare. A Mashad la fondazione Astan Qods, la Sacra Porta, è il maggiore proprietario immobiliare e terriero dell’Iran e gestisce imprese anche all’estero, dal Libano alla Siria, dall’Iraq all’Algeria.
L’impero dei Pasdaran, valutato in cento miliardi di dollari, è altrettanto esteso e pervasivo: petrolio, gas, telecomunicazioni, banche, ospedali, cantieri navali, industrie belliche, centri commerciali, società di import-export. Rouhani ha costretto i Guardiani a cedere allo stato il controllo di alcune società e numerosi ufficiali coinvolti in casi di corruzione e in scandali finanziari sono finiti in carcere.
“I Pasdaran hanno una funzione militare fondamentale ma non devono occuparsi di importare cosmetici” afferma l’economista Saeed Leylaz, che all’epoca di Ahmedinejad è stato rinchiuso per un anno nel carcere di Evin. “Dobbiamo ricostruire un’economia che è stata distrutta. Abbiamo un settore pubblico elefantiaco e inefficiente, un deficit commerciale di 25 miliardi di dollari, tre milioni di persone che vivono con meno di due dollari al giorno, 25 milioni sotto la linea della povertà e un milione e mezzo di laureati che non trovano lavoro. Le riforme non possono più aspettare”. Quella sanitaria, la cosiddetta Rouhanicare, che ha esteso l’assistenza agli indigenti privi di copertura assicurativa, è finora l’unica di rilievo sociale.
Tehran ha oltre 12 milioni di abitanti. Bisogna scendere a piedi lungo i 15 chilometri di Vali Asr, il viale del Maestro del Tempo che da nord a sud spacca in due la capitale, per immergersi nel cuore politico ed economico dell’Iran.
Nei quartieri alti di Niavaran e Shemiran, alle pendici dei monti Alborz, le lussuose dimore della vecchia borghesia imperiale ospitano ministri, diplomatici, mercanti d’arte e uomini d’affari che fanno la spola tra Londra, Parigi e Los Angeles. I giovani viaggiano in Suv, vanno a sciare sulle piste di Dizin e organizzano feste con caviale e champagne. Le ragazze fanno shopping nelle boutique di Versace e Chanel, si rifanno il naso nelle cliniche specializzate in rinoplastica, usano quintali di trucco e nessuno si scandalizza se sfoggiano il foulard il bilico sulla nuca per mostrare il kakol, la ciocca dei capelli. Gli studenti salgono in collina nel weekend, per fare musica e fumarsi una canna in pace, nei parchi di Darband e di Jamshidiye.
Più in basso lo scenario cambia. Traffico paralizzato, aria inquinata, odore di kebab e di frittelle: è la città della piccola e media borghesia, degli uffici, delle università, dei musei, dei centri commerciali, dei murales con le immagini dei martiri e dei grandi ayatollah. Nella moschea Abol Fazl mi accoglie l’hojatoleslam Safavi, un teologo conservatore che cerca di spiegarmi il dogma del velayat-e-faqih, il “governo del dottore della Legge” iscritto da Khomeini nella costituzione, che garantisce alla Guida suprema l’ultima parola sugli affari religiosi, politici e militari. L’hojatoleslam espone anche la singolare ricetta autarchica formulata dal Rahbar per uscire dalla crisi: “Un’economia di resistenza: tagliare le importazioni e sviluppare l’industria nazionale. Non abbiamo solo idrocarburi: possiamo esportare armi, tappeti, pistacchi…”
Al bazaar, però, di tappeti se ne vendono pochi. “Dopo l’accordo sul nucleare speravamo in una ripresa” dice Nader Ameri nella sua bottega colma di kerman e di balochi. “Di turisti non se ne vedono e le carte di credito sono ancora vietate. Ho qualche cliente iraniano, qualche russo, un po’ di cinesi. Ma il mercato è fermo. E le tensioni internazionali non fanno ben sperare”.
Lo scontro con l’Arabia Saudita per la supremazia geopolitica in Medio Oriente, che in Yemen è già una guerra per procura, si è inasprito con l’elezione di Trump. “Nella sua prima visita all’estero Trump ha venduto 110 miliardi di armamenti ai sauditi” sottolinea Shaikh-ul-Eslam, uno degli studenti che nel ’79 occuparono il “nido di spie” americano, ex ambasciatore in Siria e per 16 anni viceministro degli Esteri. “I sauditi, e soprattutto il principe ereditario Mohammad ben Salman, sono i principali responsabili dell’instabilità della regione. Bombardano lo Yemen, hanno sequestrato il premier libanese Hariri, ricattano il Qatar, finanziano i gruppi fondamentalisti wahhabiti. E saremmo noi i terroristi? Noi che abbiamo sacrificato i nostri martiri per combattere lo Stato islamico?”
Nelle strade del centro sono spuntate negli ultimi anni centinaia di filiali bancarie: le gente si mette in coda per comprare dollari, bene rifugio per difendersi dall’inflazione, o si affidano ai cambiavalute illegali che affollano i marciapiedi di Manoucheri, la via degli antiquari ebrei. Molti hanno chiuso i battenti, ma Simon Saidian, 70 anni, è ancora al suo posto, in una cavernosa bottega zeppa di cianfrusaglie, antiche miniature, menorah e stelle di David. “Al tempo dello scià” racconta “in Iran eravamo più di centomila. Oggi siamo scesi a 20-30 mila, ma siamo sempre la più grande comunità ebraica del Medio Oriente dopo Israele. A Tehran ci sono venti sinagoghe. E nessuno ci manca di rispetto”.
All’ospedale ebraico Sapir incontro il dottor Siamak Morsadegh, l’unico deputato ebreo eletto al majlis, il parlamento. “Siamo qui da tremila anni e ci sentiamo iraniani” spiega. “Non ci sono mai stati i ghetti. La tolleranza fondata sui principi religiosi è parte della storia e della cultura persiana. Siamo liberi di applicare la legge ebraica in materia di diritto familiare, pubblichiamo riviste, lavoriamo con le donne, gli studenti, i musicisti. Qui siamo al sicuro. E nell’ospedale che dirigo il 90 per cento dei pazienti è musulmano”.
Gli chiedo cosa pensa di Israele: il Mossad aiutò Tehran a organizzare la Savak, la famigerata polizia segreta dello scià; poi Khomeini ruppe i rapporti diplomatici con Tel Aviv e regalò l’ambasciata israeliana all’Olp di Yasser Arafat. “C’è una differenza” dice “tra essere ebrei e approvare la politica del governo Netanyahu: opprimere e discriminare i palestinesi seve solo ad alimentare l’odio e l’antisemitismo”.
All’estremo sud della metropoli viale Ali Asr si perde negli anonimi quartieri dei sobborghi popolari: verso l’aeroporto, verso il colossale mausoleo dell’imam Khomeini, verso lo sterminato cimitero dei martiri dove il venerdì le vedove infagottate nel nero chador vengono a piangere i caduti delle guerre in Siria e in Iraq. In questa plumbea periferia meridionale la disoccupazione e l’emarginazione sociale sono una cruda realtà. Sotto i viadotti e negli scantinati, i tossici accendono fuochi di carta per sciogliere la polvere nel cucchiaio: l’eroina afghana costa poco, meno degli alcolici che arrivano di contrabbando dalla Turchia e dal Kurdistan col benestare dei Pasdaran. In Iran sono quasi dieci milioni i consumatori di oppiacei, antidepressivi e droghe sintetiche.
Anche di notte Tehran pulsa di vita. I ristoranti sono strapieni. Al teatro Paliz va in scena “The Blue Pink”, una commedia sui transessuali: nel Paese dei paradossi il cambio di sesso, che il Corano non vieta, è legalmente autorizzato da una fatwa di Khomeini. E nelle 120 gallerie d’arte della città si susseguono le mostre di fotografi, pittori e scultori iraniani e stranieri. L’Argo Factory, una vecchia fabbrica di birra trasformata in spazio espositivo, ospita le installazioni interattive d’avanguardia di due artisti arrivati dalla Francia e dalla Corea.
L’80 per cento degli iraniani è nato dopo la rivoluzione. E i più giovani abitano, come ovunque nel mondo, nell’universo virtuale globalizzato. Quasi tutti hanno uno smartphone. Si spostano con Snapp, l’Uber iraniano. Comunicano via internet e Instagram. S’incontrano sui social. Si scambiano messaggi su Telegram (40 milioni di utenti). Ricorrono a Psiphon, una Vpn, per bypassare i filtri del governo e connettersi ai link bloccati: Facebook, Bbc, YouTube e Twitter, che Rouhani e la Guida suprema usano ogni giorno ma sono vietati agli iraniani.
Reza, che a 25 anni sta lavorando al suo primo romanzo, mi porta in un coffee shop dove ascoltando Dylan e Van Morrison si discute di letterattura: Melville, Calvino, Ginberg, Borges, Bukowski. Poi saliamo a un terzo piano nella casa-studio dei Vulture Head, artisti visuali che preparano un progetto di animazione e un video per il gruppo rock King Raam. “Viviamo nel Paese degli ayatollah” dicono. “Ma con la testa siamo a Parigi, a Pechino, a New York. L’Iran è sempre stato un ponte tra oriente e occidente. E lo sarà anche domani: con o senza Trump, con o senza Khamenei”.