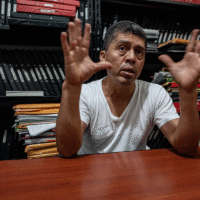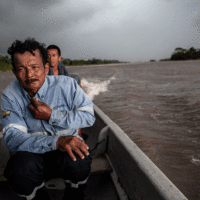Death in the Amazon
Un’anaconda dalle spire di ferro striscia lungo i fiumi dell’Amazzonia, sale a 4.000 metri tra i vulcani della cordigliera andina, attraversa gli altopiani e scende sui fianchi delle montagne per vomitare la sua nera bile di greggio nelle cisterne e nelle raffinerie di Esmeraldas, sulla costa del Pacifico. È il Sote, il Sistema de oleoducto transecuatoriano. Nasce ai margini di una sciatta cittadina sorta alla rinfusa negli anni Sessanta al confine colombiano: si chiamava Nueva Loja, ma i primi oilmen che sbarcarono nell’inesplorato Oriente ecuadoregno la ribattezzarono Lago Agrio, come Sour Lake, nel Texas, quartier generale della Texaco.
Bisogna venire qui, in questa terra di frontiera a ridosso delle coltivazioni di coca del Putumayo, rifugio di narcos e di guerriglieri, per capire il terremoto che in ottobre ha investito l’Ecuador: 8 morti, 1.340 feriti, 1,192 arresti in due settimane di scontri innescati dall’abolizione dei sussidi sul carburante, il presidente Lenín Moreno costretto a trasferirsi da Quito a Guayaquil, a decretare il coprifuoco, lo stato di emergenza. E a fare marcia indietro ritirando i provvedimenti contestati dalla popolazione in rivolta.
“Moreno” sostiene Galo Mora, scrittore, ex ministro della Cultura ed ex segretario di Alianza País, il partito che nel 2007 catapultò alla presidenza l’izquierdista Rafael Correa, oggi in esilio, “ha rinnegato le politiche sociali del governo Correa, di cui pure aveva fatto parte, e si è piegato ai dettami neoliberistici di Washington e del Fondo monetario. Gli Usa non ci hanno mai perdonato la chiusura della base militare di Manta, l’annullamento del debito estero e la rinegoziazione degli accordi con le compagnie petrolifere, le cui royalties sono passate dall’80 al 20 per cento”.
L’ex imperio globale, in ritirata dal Medio Oriente, incalzato da Pechino e Mosca sullo scacchiere internazionale, starebbe in sostanza riaffermando la propria influenza nel tradizionale backyard latinoamericano, dove esplodono le contraddizioni di un modello di sviluppo che privilegia il profitto a vantaggio delle grandi oligarchie finanziarie e penalizza la classe media, gli strati più poveri della popolazione, le comunità rurali. E se nella Bolivia di Evo Morales, destituito in novembre da un golpe politico-militare, l’analfabetismo è stato azzerato, il tasso di povertà si è dimezzato e il pil, in tredici anni di governo “indigenista”, ha mantenuto una crescita media del 4,9 per cento, nell’Ecuador di Moreno, come nel Cile di Piñera e nel Brasile di Bolsonaro, le disuguaglianze hanno raggiunto livelli insostenibili. Ad arricchirsi sono soprattutto le multinazionali dell’energia e delle materie prime.
A Lago Agrio, a Coca, sulla via Auca, lungo il corso del San Miguel e del Putumayo, il saccheggio dell’Amazzonia è un pugno allo stomaco: pozzi di petrolio, tralicci di perforazione, ruspe, autocisterne, pipeline che rasentano le case, strade che sventrano la selva, fiaccole di combustione, depositi di greggio, stazioni di raccolta e di stoccaggio.
Pablo Fajardo, l’avvocato che dal 1993 si batte per ottenere la riparazione dei danni umani e ambientali provocati dall’inquinamento petrolifero, mi riceve negli uffici sommersi dai faldoni legali dell’Udapt, l’Unione delle vittime delle operazioni petroliere della Texaco. “Da qui si estraggono 518 mila barili al giorno” dice Fajardo. “Ma le quattro province del Sucumbios e dell’Orellana dove da 52 anni si produce petrolio sono le più povere del Paese. Dove finiscono i profitti? Certo non alla popolazione locale. In questa zona ci sono 470 mecheros, le torri di combustione: molte sono accese, altre emettono residui tossici che si liberano nell’atmosfera. Perché qui non si usa la tecnologia che consente di utilizzare o reiniettare il gas? Milioni di dollari vanno in fumo mentre l’Ecuador deve importare il gas per uso domestico!”
Per vent’anni la Texaco, assorbita nel 2001 dalla Chevron, ha sfruttato i pozzi petroliferi dell’Oriente ecuadoregno in spregio alle più elementari norme di salvaguardia del territorio: 650 mila barili di greggio e 60 milioni di tonnellate di acque oleose sono state sversate nei fiumi, nella foresta e in almeno 880 “piscine”, buche a cielo aperto prive di adeguato isolamento, che hanno inquinato la falda freatica e il sistema idrico della regione. Le popolazioni indigene che nei fiumi pescavano, si lavavano e si abbeveravano sono state decimate. Le patologie causate dalla contaminazione sono aumentate a ritmi vertiginosi: tumori, aborti spontanei, malattie della pelle, malformazioni congenite, danni neurologici e cerebrali.
Nel 2007 la proposta di Rafael Correa di congelare in cambio di finanziamenti internazionali l’estrazione di petrolio nel parco Yasuní è caduta nel vuoto. La sentenza del giugno 2018 della Corte costituzionale ecuadoregna che impone alla Chevron di pagare 9,5 miliardi di dollari in riparazioni è stata rigettata dalla Corte di arbitrato dell’Aja. E l’attuale governo, nonostante l’esito contrario di un referendum nel febbraio 2018, ha assegnato nuove concessioni alla Petroecuador, la società petrolifera nazionale, e alle compagnie straniere che operano nel Yasuní: l’area del mondo che vanta la più alta concentrazione esistente di specie animali e vegetali, dichiarata riserva della biosfera dall’Onu. La battaglia legale prosegue, ma intanto il petrolio continua a uccidere.
Donald Moncayo, dirigente dell’Udapt che mi accompagna nella selva, solleva col badile uno strato di foglie e terriccio in un campo dove tutti gli alberi sono stati abbattuti. “Una delle piscine” spiega rivoltando una melma bituminosa di fango e di catrame. “Ce ne sono centinaia in questa zona”. Poco distante la jeep si ferma davanti a una baracca di legno col tetto di zinco. È la casa di don Octavio Cordoba, 85 anni, otto figli, che dal 2011 fa la chemio per combattere un tumore: “Siamo pieni di petrolio” dice. “Ma tutta la ricchezza se ne va in quei tubi. Non resta niente per noi”.
Storie di vite spezzate, di sofferenze patite in silenzio. Nel municipio di Dureno, tra i più inquinati, doña Hilda Navarro abita a due passi dall’oleodotto e da una discarica di liquami tossici. È stata operata quattro volte per un tumore al cervello e tira avanti con la morfina. Non parla, non cammina. Suo marito José non può lasciarla sola: guadagna qualche dollaro lavando i vestiti dei vicini. Nel patio di un’altra baracca doña Sonia Sanchez è stesa su un’amaca con la febbre alta per la dengue. Due mesi fa le hanno asportato le ovaie. “Qui” dice “quasi tutte le donne hanno tumori e aborti spontanei”.
In canoa attraversiamo il rio Aguarico per raggiungere il villaggio di una comunità indigena. Racconta Doña Marina, moglie dell’ultimo sciamano dei Cofánes: “Ho un cancro alle vie urinarie. Bevevo l’acqua del fiume, come tutti. Non sapevamo che era contaminata. Prima vivevamo di caccia e pesca, raccoglievamo i frutti e le piante della foresta. Poi i pesci e gli uccelli hanno cominciato a morire. E i nostri bambini si sono ammalati. Il petrolio è la nostra rovina”.
Chi non lavora nell’industria estrattiva sopravvive zappando i campi. Come Santos Gonzaga, campesino nel comune di General Farfan, a poche centinaia di metri dal confine colombiano, che coltiva caffè e cacao in una finca supportata dall’ong italiana Cefa. “Un sacco da 46 chili di caffè non essiccato si vende a 12 dollari” spiega. “Troppo poco per poter assumere operai. Faccio tutto da solo, con l’aiuto di mia moglie e dei miei figli”.
I 720 chilometri della frontiera con la Colombia sono una terra di nessuno dove operano gruppi paramilitari, trafficanti di armi, di legname e di combustibile, minatori illegali e killer al soldo dei cartelli della droga. Nel Putumayo sono più di 30 mila gli ettari coltivati a coca e l’Ecuador, con la sua economia dollarizzata, è diventato il paradiso del riciclaggio di denaro sporco: confina con il maggiore produttore di “neve” del pianeta e utilizza la valuta del più grande importatore al mondo di cocaina. Le due principali rotte della droga, quella amazzonica e quella del Pacifico, passano per le vie fluviali e per l’impenetrabile foresta pluviale dove i controlli sono inesistenti e la corruzione è endemica. Il traffico è gestito da ex combattenti delle Farc colombiane (Fronte Oliver Sinisterra e Los Comuneros), ex mercenari delle Auc, le formazioni paramilitari antiterrorrismo (La Constru) e narcos messicani (cartello di Sinaloa).
I ficcanaso non sono graditi. Nel marzo 2018 il giornalista di El Comercio Javier Ortega, il fotografo Paúl Rivas e il loro autista Efraín Segarra sono stati sequestrati e uccisi nei pressi del confine. E negli ultimi 18 mesi a Lago Agrio la polizia ha registrato una decina di omicidi in regolamenti di conti tra bande rivali.
In questo clima d’insicurezza e d’instabilità politica, con il 22 per cento della popolazione sotto la soglia di povertà, il 16,5 per cento sottonutrito, il 15 per cento privo di servizi igienici e 250 mila minori costretti a lavorare, il “paquetazo”, le misure di austerità approvate dal governo in cambio di un prestito di 4,2 miliardi di dollari del Fondo monetario, ha avuto l’effetto di un detonatore. Lenín Moreno ha giustificato il piano di aggiustamento strutturale, che prevede drastici tagli alla spesa pubblica, comprese sensibili riduzioni dei salari nel settore statale, con l’esigenza di riequilibrare i conti e ridurre un debito estero che ammonta a oltre 50 miliardi di dollari. Per aumentare la produzione di petrolio ha anche deciso che l’1 gennaio 2020 l’Ecuador uscirà dall’Opec. Ma dopo le violente proteste di ottobre ha dovuto recedere, almeno in parte, dai provvedimenti più impopolari.
In prima linea nelle manifestazioni c’erano le donne, i campesinos, gli abitanti dei quartieri poveri della capitale, i tassisti, gli autotrasportatori, gli studenti che si oppongono al progetto di consentire all’aviazione militare americana l’utilizzo di un aeroporto alle isole Galápagos. C’erano soprattutto i popoli indigeni che si battono contro le perforazioni petrolifere: appena un decimo dei 17 milioni di ecuadoregni, eppure capaci di mobilitare le piazze.
“Il movimento indigeno è la sola forza in grado di paralizzare il Paese e di costringere il governo al tavolo delle trattative” afferma Mario Melo, direttore del centro dei diritti umani dell’università cattolica di Quito. “Nei decenni scorsi hanno svolto un ruolo centrale nella rimozione di tre presidenti”.
Piove a dirotto nella selva di Dureno, gli stivali affondano nel fango. “Senti quel sibilo?” dice Donald. “All’inizio gli indigeni erano terrorizzati: dicevano che un animale maligno era uscito dalle viscere della terra”. Il sentiero sbuca in una radura circondata da una rete metallica. Al centro la testa di un pozzo di petrolio, più in là una fiaccola che brucia e un tubo verticale che esala un soffio sinistro: “L’animale che sputa il gas. La bestia che uccide la foresta e gli uomini”.