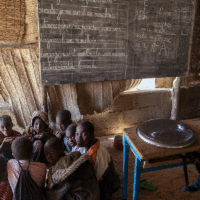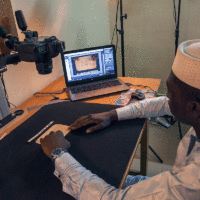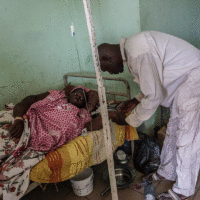Books on the brink
Baffi curati, babbucce ai piedi, l’elegante kufi a celare la calvizie e un caftano a scacchi su un corpulento fisico di mezza età. Nel suo ufficio al secondo piano di un’anonima palazzina di Baco-Djicoroni, un polveroso quartiere alla periferia di Bamako, Abdel Kader Haidara non ha l’aspetto di uno spericolato Indiana Jones del Sahara. Ma quest’uomo dall’aria mite e dallo sguardo acuminato è l’artefice di un’impresa temeraria: ha salvato la più grande collezione di manoscritti arabi esistente al mondo dalla probabile distruzione per mano dei jihadisti di al-Qaida.
È la primavera del 2012 e il nord del Mali è nel caos. Dopo il crollo del regime libico, le milizie della Legione islamica di Gheddafi hanno saccheggiato gli arsenali e si sono riversate nella terra di nessuno tra il Ciad e la Mauritania con un impressionante bottino di automezzi, munizioni, mitragliatrici, missili terra-aria, Rpg e quintali di esplosivo Semtex. In Mali i separatisti tuareg del Mnla, il movimento che da decenni si batte per l’indipendenza dell’Azawad (“il Paese dei pascoli”), si sono coalizzati con i gruppi salafiti, Ansar ad-Din e Aqmi (al-Qaida nel Maghreb islamico). Mentre a Bamako una giunta militare destituisce il presidente Toumani Touré, i ribelli conquistano Kidal e Gao. E alla fine di marzo sono alle porte di Timbuctu.
Abdel Kader è in allarme. Nessuno più di lui è consapevole del pericolo che incombe sui tesori custoditi nelle biblioteche. È uno dei 14 figli di Mohammed “Mamma” Haidara, erudito locale e collezionista di codici antichi, e ha dedicato la propria vita ai libri. Tra il 1984 e il 2000 ha rovistato nei villaggi della regione alla ricerca di manoscritti per conto dell’Ahmed Baba institute, il centro studi creato nel ’73 dall’Unesco. Solo nella biblioteca di famiglia, intitolata al padre, ve ne sono più di 16 mila. E nel ‘96 ha fondato la Savama (Associazione per la conservazione e la valorizzazione dei manoscritti), una ong che raggruppa una ventina delle 45 raccolte private di Timbuctu. Che ora sono alla mercè di un’orda di fanatici armati.
Bruce Chatwin sosteneva che esistono due Timbuctu: “Il luogo reale, una logora città carovaniera dove il Niger si protende nel Sahara; e quella del mito, la Timbuctu della mente”. La misteriosa e irraggiungibile città del deserto è da millenni sulla mappa dell’immaginario collettivo. Erodoto, nel V secolo avanti Cristo, favoleggia di una contrada “abitata da maghi e stregoni in riva a un fiume pieno di coccodrilli”; e cinquecento anni dopo Plinio il Vecchio narra di mostruose tribù di trogloditi “metà uomini e metà bestie”. Nel Medioevo, quando due terzi dell’oro circolante in Europa proviene dal Bilad as-Sudan, il “Paese dei negri”, geografi e viaggiatori alimentano la leggenda. Al-Idrisi racconta di un sovrano che possedeva una pepita d’oro di 15 chili. Al-Omari riferisce che quando il mansa (re del Mali) Musa decise di compiere il pellegrinaggio alla Mecca nel 1324, si fece accompagnare da un seguito di 60 mila uomini, 12 mila schiavi e centinaia di dromedari che oltre alle concubine e alle provviste trasportavano due tonnellate d’oro in polvere e lingotti.
Gli storici attribuiscono le fortune della città alla sua posizione strategica sull’ansa del Niger. Tum-Buctu, “il pozzo di Buctu”, dal nome della schiava tuareg cui era stata affidata la custodia di un piccolo accampamento, crebbe fino a diventare il principale terminal commerciale delle piste transahariane: da sud le carovane portavano avorio, gomma, spezie, noci di cola, legni pregiati, oro e schiavi; dal Mediterraneo affluivano nei suoi empori sale, zucchero, stoffe, barre di ferro e di rame, armi e rari testi su pergamena.
Il primo a menzionarli fu Leone Africano (Hasan ibn Muhammad al-Wazzan al-Zayyati), nel 1509: “Vi si acquistano numerosi manoscritti provenienti dalla Barberia, e i ricavi derivanti dalla loro vendita superano quelli di ogni altra merce”. Timbuctu faceva parte a quell’epoca dell’impero Songhai ed era una delle grandi capitali economiche e culturali dell’Africa sub-sahariana, con decine di moschee e 180 scuole coraniche frequentate da celebri giuristi e letterati. I copisti trascrivevano i libri di argomento religioso e secolare che riempivano gli scaffali delle collezioni pubbliche e private.
Poi le guerre, le carestie e lo spostamento a oriente delle rotte commerciali innescarono un inesorabile declino: Timbuctu, seppellita dalle dune e dall’oblio, finì per diventare un’irrilevante borgata di provincia. “Un ammasso di stamberghe di fango” scrive l’esploratore francese René Caillié nel suo Journal d’un voyage à Tembouctou (Parigi, 1830) “mal costruite, circondate da immense distese di sabbia e dalla più grande aridità”. Ma lo scozzese Gordon Laing, che nel 1826 fu il primo europeo a varcare la soglia della città, aveva trovato qualcosa d’interessante: libri, che gli furono rubati quando sulla via del ritorno venne aggredito e trucidato. E altri libri, a migliaia, lasciarono allibito nel 1853 il tedesco Heinrich Barth, che tornò in patria per raccontarlo. Finché alle soglie del XX secolo fu il giornalista Félix Dubois a rivelare ai lettori del Figaro di avere scoperto il segreto di Timbuctu la Misteriosa: il tesoro sepolto erano le sue biblioteche.
Nella primavera del 2012 Abdel Kader Haidara ha un pensiero fisso: salvare i manoscritti. L’1 aprile i tuareg del Mnla entrano a Timbuctu mentre l’esercito batte in ritirata senza sparare un colpo. Ma pochi giorni dopo la bandiera nera di al-Qaida soppianta il tricolore indipendentista: i jihadisti s’impadroniscono della città.
A guidarli è un triumvirato di incalliti tagliagole. Ne fanno parte Abdelhamid Abou Zeid, che si proclama “emiro di Timbuctu”, un terrorista algerino afflitto da rachitismo, ex membro del Gruppo salafita per la Predicazione e il Combattimento: un killer spietato, responsabile di eccidi, rapimenti e decapitazioni di prigionieri europei; Iyad Ag Ghali, il leader della rivolta tuareg degli anni Novanta, ambiguo mediatore nelle trattative per il rilascio di numerosi ostaggi occidentali ed ex console maliano a Jeddah, radicalizzato dalla setta islamista Tablighi Jama’at e fondatore di Ansar ad-Din; e il famigerato terrorista algerino Mokhtar Belmokhtar, leader del gruppo qaedista al-Murabitun, un ex veterano dell’Afghanistan detto laouar, il guercio (ha perso un occhio combattendo), noto anche come Mr. Marlboro: ha intascato decine di milioni di dollari col traffico di sigarette, droga, armi e migranti tra il golfo di Guinea e il Nordafrica.
A Timbuctu gli occupanti impongono la sharia. La polizia fa a pezzi le bottiglie di alcolici, vieta la musica e le feste, costringe le donne a indossare il velo e trasforma in carcere femminile l’angusto locale del bancomat nella sede della Banque Malienne de Solidarité. Il tribunale islamico applica le pene hadd: frustate, amputazione di mani e piedi ai ladri, lapidazione per rapporti sessuali illeciti. Mentre un terzo dei 54 mila abitanti abbandona la città, Abou Zeid s’insedia nell’ex villa di Gheddafi e rinchiude alcuni ostaggi francesi nella nuova sede dell’Ahmed Baba Institute costruita nel 2009 dai sudafricani, di fronte alla moschea Sankoré.
Gli oltre 300 mila manoscritti conservati nell’istituto e nelle biblioteche private sono in pericolo. E l’allarme cresce quando i jihadisti si scagliano contro i simboli della città e contro le tombe dei santoni sufi: demoliscono il sepolcro di Sidi Mahmud e altri nove mausolei, sfondano la porta occidentale della moschea Sidi Yahya, che secondo la tradizione era destinata a restare chiusa fino alla fine dei tempi, e si accaniscono sul monumento equestre di al-Farouk, il talismanico jinn che protegge la città dagli spiriti maligni.
“Non c’era un minuto da perdere” racconta Haidara. “Chiesi alla Fondazione Ford il permesso di usare i 12 mila dollari di una borsa di studio e invece di andare a Oxford cominciai a comprare bauli”. Il piano, messo a punto in riunioni clandestine con altri bibliotecari, è un azzardo. È indispensabile la massima segretezza. Un numero ristretto di persone di fiducia deve penetrare nottetempo nelle biblioteche, riempire di manoscritti le casse di metallo, i sacchi di riso e i bauli, caricarli sui push-push, i barrocci tirati dagli asini, e trasportarli in abitazioni sicure. Il passo successivo, il viaggio da Timbuctu a Bamako, è ancora più rischioso. “Stavamo trafugando migliaia di delicatissimi documenti sotto il naso dei terroristi” ricorda Haidara. “E dovevamo spedirli con mezzi di fortuna per centinaia di chilometri di deserto, superando i posti di blocco, su piste e strade infestate da banditi. Allah è stato clemente!”
Alla metà di settembre 24 mila manoscritti dell’istituto Ahmed Baba sono a Bamako. A Timbuctu è però rimasto l’85 per cento del patrimonio complessivo: quello custodito nelle biblioteche private. Haidara si rimette in moto: interpella l’Unesco, la fondazione Gerda Henkel, il centro Juma al-Majid di Dubai, la cooperazione svizzera, l’università di Amburgo. Un pool di donatori (Prince Claus Fund, Doen e Ford Foundation, le ambasciate tedesca e olandese) s’impegna a coprire le spese fino a un milione di euro: la seconda fase dell’evacuazione può cominciare.
Ma all’inizio del 2013 la situazione si complica. Parigi interviene per bloccare l’avanzata dei jihadisti, aerei ed elicotteri bombardano i convogli dei ribelli, le strade sono impraticabili e 900 bauli con 136 mila manoscritti sono ancora a Timbuctu. L’unica via d’uscita è il fiume. Non resta che ricorrere alle pinasse: su ognuna delle lunghe canoe di legno scuro vengono caricate non più di 15 casse. Le piroghe fanno la spola con Djenné, 223 miglia a sud, dove avviene il trasbordo del carico su camion e taxi presi a nolo da Haidara, che dirige le operazioni dalla capitale a stretto contatto telefonico con uno stuolo di corrieri, autisti e barcaioli. Quando il 28 gennaio i parà francesi liberano Timbuctu, 377.491 manoscritti sono già al sicuro in una ventina di appartamenti di Bamako. Mancano all’appello 4.203 codici dell’istituto Ahmed Baba, rubati e in parte bruciati dai terroristi in fuga. Ma la paventata catastrofe, paragonata dagli studiosi alla distruzione della biblioteca di Alessandria, è stata scongiurata.
Cinque anni dopo, nella sede della Savama a Bamako, i lavori proseguono. “Tutti i documenti” spiega Haidara “devono essere inventariati, restaurati, catalogati, digitalizzati e archiviati in contenitori di materiali privi di acidi che realizziamo nei nostri laboratori. Ci vorrà molto tempo”. Pagina dopo pagina, i manoscritti vengono fotografati e salvati su dischi rigidi che vengono spediti alla Hill Museum and Manuscript Library di Collegeville, nel Minnesota: il più accreditato centro di ricerca al mondo per lo studio dei testi antichi, gestito dai monaci benedettini dell’abbazia di Saint John’s. “Anche se l’umidità di Bamako rischia di danneggiarli” dice il direttore della Savama “non possiamo riportare i libri al nord. I jihadisti sono ancora lì”.
Il bimotore Beechcraft delle Nazioni Unite è il solo mezzo per raggiungere la “città dei 333 santi”, che è oggi un avamposto militare dove sono acquartierati i soldati maliani, i caschi blu della Minusma (la missione Onu) e i reparti francesi dell’operazione Barkhane, asserragliati all’aeroporto. A Timbuctu sono l’unico toubab in abiti civili e all’hotel Colombe mi avvertono di stare attento: copriti il viso col turbante, mantieni un profilo basso, bada di non essere seguito e all’imbrunire chiuditi in camera. Il business dei sequestri è redditizio: ci sono ovunque informatori e infiltrati.
I gruppi armati hanno stretto una nuova alleanza, la Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslimin (Organizzazione di sostegno all’islam e ai musulmani), guidata dal leader di Asnsar ad-Din Iyad Ag Ghali, di cui fanno parte Hamadou Koufa, fondatore del Fronte di liberazione del Macina, il braccio destro di Belmokhtar, Abderrahman al-Sanhaji, il qadi di Aqim nel Sahara Jamal Oukacha e il vicecapo di al-Murabitun Hassan al-Ansari. Negli ultimi mesi hanno alzato il tiro, intensificando gli attentati ai convogli umanitari e alle basi dell’esercito. In gennaio hanno ucciso 14 soldati maliani e 26 civili. In febbraio una mina artigianale ha falciato due militari francesi a Gao. In marzo si sono spinti a Ouagadougou, in Burkina Faso, dove hanno attaccato l’ambasciata francese e il quartier generale delle forze armate.
Nell’assenza totale dello stato, con i giovani senza lavoro, i prezzi che aumentano e un governo malato di corruzione e nepotismo, gli insorti hanno buon gioco. “Durante l’occupazione c’era più sicurezza. Ora nessuno ci protegge” afferma Isa, che un tempo faceva la guida turistica. “Sono i ribelli a controllare la strada tra qui e Goundam. Un mese fa hanno tagliato le mani a due banditi: hanno fatto bene!” Tra la popolazione araba della città, un mosaico di etnie bambara, tuareg, peul e songhai, c’è chi sostiene che gli occupanti garantivano un minimo di giustizia, proteggevano i pastori nomadi durante le migrazioni e promettevano la redistribuzione delle terre ai contadini.
Su Timbuctu grava un’atmosfera pesante, carica di tensione e di sospetto. I profughi stanno lentamente tornando, i mausolei distrutti sono stati ricostruiti e le ragazze hanno ripreso a truccarsi e a indossare i jeans. Ma sotto una parvenza di precaria normalità, i segni della guerra e dell’abbandono sono evidenti. Agli incroci stazionano i mezzi blindati dell’esercito, molti negozi restano chiusi, gli alberghi sono vuoti e il commercio è ridotto al minimo: la maggior parte dei beni di consumo in vendita nei mercati arriva a singhiozzo dall’Algeria. E al calar del sole la gente si barrica in casa.
La prolungata siccità, l’assenza di trasporti e l’incombente minaccia delle bande armate provocano una diffusa insicurezza alimentare e un alto tasso di malnutrizione. Il Wfp distribuisce riso fortificato e legumi a 207 scuole della zona. Ma nei centri sanitari e nei dilapidati ambulatori mancano medici e medicinali. “Abbiamo un solo chirurgo e due anestesisti” dice il direttore dell’ospedale regionale Karim Dambelé. “Le attrezzature sono state saccheggiate dai ribelli e non abbiamo i soldi per ricomprarle”. Nei reparti i bambini lottano per sopravvivere: Zeinab, 11 mesi, pesa sei chili; Husna, un anno, non arriva a cinque. E c’è chi sta peggio.
A mezz’ora di jeep, oltre la villa bombardata di Gheddafi e le basi militari, seguendo una pista che affonda nel letto asciutto di un canale, si arriva a un villaggio di capanne di fango sulla sponda del Niger. L’acqua è bassa, il pesce scarso, ossute vacche si aggirano nei campi riarsi. È qui che in gennaio sono approdati 1.500 profughi, abbandonando di là dal fiume i pochi averi razziati da una tribù tuareg: non hanno niente, solo qualche stuoia e fogli di plastica per ripararsi dal sole.
A Timbuctu vado in cerca di manoscritti. Il giovane imam della moschea Djingereber, Alfa Ibrahim Ben Essayouti, apre le stanze della biblioteca di famiglia, che contiene quattromila documenti. A poca distanza, nel Fondo Kati, ve ne sono più di diecimila; tremila sono custoditi dall’imam della moschea Sankoré; molti altri sono ancora nascosti in abitazioni private. “Di notte, durante l’occupazione, ho trasportato tremila volumi in luoghi sicuri” racconta Mohammed Cissé sulla porta della libreria Al-Wangari. “È bene che restino dove sono”.
Abdul Wahid Haidara è il proprietario della biblioteca dedicata al suo antenato Mohamed Tahar, che duecento anni fa si trasferì a Timbuctu dall’oasi di Arawan, sei giorni di cammello a nord, dove la famiglia originaria di Yanbu, in Arabia, si era stabilita nel XVI secolo. “Mohamed Tahar” racconta “era un grande giurista e un calligrafo famoso in tutto il Sahara. Ci ha lasciato più di duemila manoscritti”.
Mi conduce in un attiguo deposito dove tra fusti di carburante, stoviglie alla rinfusa e secchi di vernice sono accatastati i bauli di metallo. “Sono in gran parte copie del Corano e testi di diritto islamico” spiega. “Ma ci sono anche trattati di botanica, di medicina, di musica, di astronomia, di matematica. E poi lettere, poesie, preghiere sufi, contratti commerciali, ricette di pozioni magiche”. I manoscritti, che non sono rilegati ma solo racchiusi in copertine di pelle di capra o di cammello, variano nello stile di scrittura e nelle dimensioni, da pochi fogli a volumi di centinaia di pagine. Alcuni sono vergati su carta filigranata fabbricata a Venezia e a Genova nel XVI secolo, altri sono abbelliti da ornamenti calligrafici, profili di moschee e paesaggi del deserto.
Chiedendo in giro e perlustrando gli stretti vicoli di Timbuctu si fanno inattese scoperte. Come la collezione del settantaquattrenne Sidi Lamin, seminascosta nell’ovattata penombra di una stanza coperta di tappeti e foderata di scaffali imbottiti di libri. “Mio padre, Sidi Goumo, era un marabutto” dice mostrandomi un antico commento ai detti del Profeta. “È da lui che ho ereditato i manoscritti. Sono 2.453 e quando sono arrivati i jihadisti li abbiamo interrati nel cortile: non potevano trovarli”.
Dai minareti i muezzin annunciano il maghreb, la preghiera del tramonto. Mi devo affrettare, per stradine dove la sabbia inghiotte i muri sgretolati di argilla e i portoni si chiudono dietro i chiavistelli. La notte scende in fretta, gelida e stellata, e il guardiano dell’albergo ha già acceso i carboni nel braciere del tè. Il silenzio è rotto solo dai belati delle capre, dal passaggio di un motorino, dal suono di un flauto.
Quali tesori cela ancora la misteriosa città del deserto? Quali incognite? Si sentono spari in lontananza. Uomini senza volto sono in agguato tra le dune.