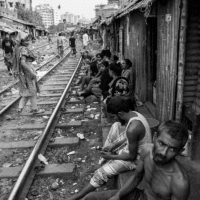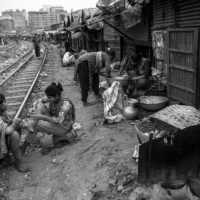Blood on the tracks
Il suo nome è Manik, ma alla stazione di Komlapur tutti lo chiamano Jewel, gioiello. Ha perso le gambe cadendo sotto il treno mentre chiedeva l’elemosina e il fuoco che ha distrutto il tugurio dove abitava gli ha lasciato sul petto una ragnatela di cicatrici. Khadija, la sua migliore amica, è una ragazzina di 14 anni che non è mai andata a scuola e non ha conosciuto i genitori: si prostituisce per 50 taka, mezzo euro, nei vagoni dismessi e nel boschetto sotto il passaggio pedonale. I poliziotti, per 10 taka, chiudono gli occhi.
Il Bangladesh, una delle nazioni più povere e densamente popolate del pianeta (163 milioni di abitanti stipati in 144 mila kmq, meno della metà dell’Italia), ha celebrato in pompa magna il 48° anniversario dell’indipendenza con l’annuncio che nel 2024 uscirà dalla lista Onu degli stati “meno sviluppati” per entrare nel gruppone dei “Paesi in via di sviluppo”. I parametri macroeconomici sono promettenti: tasso di crescita al 6 per cento, alfabetizzazione al 72 per cento, reddito pro capite che ha superato la soglia minima richiesta di 1.230 dollari l’anno. Ma per Jewel, per Khadija e per decine di milioni di bengalesi che sopravvivono a stento nella miseria più abietta, queste cifre non hanno alcun significato.
“Il divario tra ricchi e poveri, invece di decrescere, continua ad aumentare” afferma l’economista Abu Afsarul Haider, che elenca una lunga serie di problemi strutturali irrisolti: disparità di accesso all’istruzione, ai servizi sanitari e al credito, disoccupazione, sfruttamento della manodopera, salari risibili, corruzione, insicurezza alimentare, carenza di alloggi. La pressione demografica, l’acuirsi della questione sociale, l’instabilità politica e la strisciante avanzata dell’integralismo islamico rischiano di compromettere i risultati ottenuti dalle due begum che dopo quindici anni di regime militare si sono alternate al governo: l’attuale premier Sheikh Hasina, leader dell’Awami League, e la settantaduenne Khaleda Zia del Partito nazionalista, arrestata in febbraio con l’accusa di malversazione.
È padre Alfonso, un missionario saveriano, ad accompagnarmi nei meandri degli slum di Dacca, quinta città più inquinata al mondo, venti milioni di esseri umani soffocati dai fumi di un traffico inverosimile. Una delle baraccopoli più squallide si snoda lungo i binari della ferrovia, tra Kawran Bazar e il passaggio a livello di Tejgaon: catapecchie di lamiera e di cartone, bambini che trasportano enormi pesi sulla schiena, mucchi d’immondizia. Al fischio della locomotiva le donne agguantano i figli e si mettono al riparo: i treni, gremiti fin sopra i tetti, rasentano le abitazioni e gli incidenti, spesso mortali, sono frequenti.
Il centro traumatologico sembra un ospedale da campo dopo una battaglia. I feriti arrivano in continuazione a bordo di decrepite ambulanze e traballanti risciò a pedali: mutilati, ustionati, paraplegici costretti a comprarsi cibo, farmaci e bende nelle adiacenti botteghe, che offrono a chi può permetterselo medicinali, protesi e stampelle. La terapia intensiva è un locale semibuio con alcune brande prive di strumenti di monitoraggio: le infermiere appendono le flebo a ganci arrugginiti infissi al muro.
“C’è di peggio” sospira padre Alfonso. Nel rifugio per bambini abbandonati e prostitute gestito dai saveriani mi racconta di una bimba di quattro anni trovata in un sottoscala della stazione. “Non parlava. Sua madre, devastata dalla droga, si è impiccata: anche lei era figlia di una prostituta ed era stata abbandonata. Ho chiamato la piccola Mitali, amicizia. Se non l’avessimo portata qui sarebbe finita male: rapita e uccisa dai trafficanti di organi, o nel migliore dei casi venduta a qualche pedofilo o a un bordello”.
Il Bangladesh è uno dei pochi Paesi musulmani dove la prostituzione è legale. Si stima siano più di 200 mila le donne impiegate nell’industria del sesso. Nel megabordello di Daulatdia, aperto 24 ore su 24 a un centinaio di chilometri da Dacca, lavorano duemila ragazze: tariffe da 2 a 5 euro, 50 per una vergine. Molte sono minorenni, bambine di 10-14 anni che le tenutarie imbottiscono di yaba (amfetamina) e di Oradexon, uno steroide usato per ingrassare il bestiame, utile per gonfiare e rendere più attraenti i corpi più acerbi. E molte sono ridotte in schiavitù, imprigionate nelle sudice stamberghe del bordello fino a quando avranno rimborsato il denaro pagato per il loro acquisto.
I programmi di microcredito promossi dal premio Nobel per la pace Muhammad Yunus hanno sensibilmente migliorato la condizione delle donne. Ma in un Paese dove la nascita di una femmina è considerata una disgrazia, i matrimoni precoci sono la norma, la religione e la cultura patriarcale prevalgono sulle leggi dello stato, le statistiche sono impietose. La percentuale delle ragazze che si sposano prima dei 15 anni è la più elevata al mondo. Tre donne su quattro contraggono il matrimonio prima dell’età legale di 18 anni e due su cento sono sposate dalle famiglie prima degli 11. Le conseguenze sono irreparabili: aborti e gravidanze extrauterine, mortalità materna, abbandono della scuola, maggiore esposizione allo sfruttamento e alla violenza domestica.
L’indigenza (47 milioni di bengalesi vivono in povertà e 26 milioni in povertà estrema) e la frequenza dei disastri naturali spingono i genitori a disfarsi in fretta delle proprie figlie. Il Bangladesh detiene il record mondiale delle vittime causate da calamità atmosferiche e ambientali: cicloni tropicali, piogge monsoniche e inondazioni distruggono case, proprietà, raccolti. Ogni bocca in meno da sfamare è una benedizione. Ma può trasformarsi in una tragedia.
Sulla sponda del fetido Buriganga, il fiume avvelenato dalle fogne e dai rifiuti tossici della città, Anwara Begum ha appeso uno striscione con due foto: una ragazza a terra in una pozza di sangue e un giovane con un cappio al collo. “Mia figlia Tania aveva solo 16 anni” si dispera Anwara. “Quell’uomo, suo marito, l’ha uccisa a coltellate perché non abbiamo abbastanza soldi per pagare la dote. Vogliamo giustizia! Lo devono impiccare!” È però probabile che l’assassino sfuggirà all’arresto. Come la maggior parte dei responsabili degli stupri, 187 nei primi tre mesi del 2018 (ma i casi non denunciati sono molti di più), e degli attacchi con l’acido: in media uno ogni due giorni, altro record mondiale. L’Acid Survivors Foundation, che fornisce assistenza medica e legale alle vittime, tratta in media 450 pazienti l’anno: giovani donne storpiate nella carne e nella psiche, respinte ai margini della società, condannate a portare nei volti sfigurati l’indelebile marchio del disonore e dell’infamia.
“La violenza sessuale è una piaga diffusa, soprattutto nelle famiglie” spiega Pavlo Kolovos, capo missione di Medici senza frontiere. “Il nostro ospedale nello slum di Kamrangirchar riceve ogni giorno una quindicina di vittime”. Msf si occupa anche della salute degli operai nel “settore informale”. Nel formicaio di Kamrangirchar, un milione di abitanti in meno di 4 kmq, sono più di tremila le officine meccaniche, i laboratori per il riciclaggio della plastica, le manifatture di tessuti che lavorano in subappalto per le industria locali e straniere. L’età minima è fissata per legge a 14 anni, ma negli umidi e malsani sottoscala, nei cavernosi opifici e nelle fatiscenti palazzine dello slum sgobbano dall’alba a notte inoltrata centinaia di bambini di 8-12 anni. Stipendio medio: due euro al giorno. “Il top manager di una multinazionale dell’abbigliamento” si legge in un rapporto dell’Oxfam “intasca in quattro giorni la cifra che un operaio del Bangladesh guadagna nell’intera vita”.
Kamrangirchar è un inesauribile serbatoio di manodopera a basso costo. È qui che appronda la maggior parte dei seicentomila migranti che la mostruosa megalopoli ogni anno inghiotte: contadini che abbandonano le campagne in cerca di un impiego e rifugiati ambientali incalzati dai mutamenti climatici che stanno devastando il fragile ecosistema del Paese. Lo scioglimento dei ghiacciai dell’Himalaya, l’innalzamento del livello del mare e delle temperature, l’andamento erratico delle piogge monsoniche, l’intensificazione dei cicloni, la frequenza delle inondazioni e la progressiva salinizzazione delle zone costiere provocano immensi danni alle colture. Si calcola che il 70 per cento dei baraccati di Dacca siano scampati a un disastro naturale.
All’orizzonte si profilano intanto altre nubi minacciose: lo spettro dell’integralismo islamico e la crisi innescata dal massiccio afflusso di profughi Rohingya dal Myanmar. Il Bangladesh, musulmano al 90 per cento e tradizionalmente tollerante, ha subito negli ultimi anni un’ondata di attentati terroristici. I jihadisti hanno trucidato missionari cristiani, monaci buddhisti e hinduisti, cooperanti stranieri (tra cui l’italiano Cesare Tavella nel 2015), professori universitari, intellettuali laici, giornalisti, attivisti omosessuali e blogger tacciati di ateismo. Nel luglio 2016 hanno attaccato l’Holey Artisan Bakery, un ristorante di Dacca frequentato da stranieri, uccidendo venti persone tra cui nove italiani e sette giapponesi. Lo scorso marzo è stato gravemante ferito lo scrittore Muhammad Zafar Iqbal, accusato di esprimere opinioni anti-islamiche.
L’Awami League, che in vista delle elezioni del prossimo dicembre si preoccupa soprattutto d’incarcerare i membri dell’opposizione, punta il dito sui gruppi terroristici locali, Jamaat-ul-Mujahidin e Ansarullah Bangla Team, cercando al tempo stesso di guadagnare consensi tra i sostenitori della potente Hefazat-e-Islam, il movimento che si batte per l’introduzione della sharia e che ha già ottenuto dal governo numerose concessioni: l’equiparazione dei diplomi delle madrase alle lauree universitarie, l’eliminazione dei testi sufi nelle scuole elementari e una legge sulla cybersicurezza che limita la libertà di espressione e prevede pesanti sanzioni per chi “offende la sensibilità religiosa”. Ma non si tratta solo di una questione politica interna.
Le cellule che hanno compiuto gli attentati rivendicano la propria affiliazione allo Stato islamico e all’Aqis (al-Qaida nel subcontinente indiano), i due network del terrore in competizione per esportare la guerra santa globale nel sudest asiatico e in Bangladesh, dove i jihadisti contano di sfruttare le crescenti tensioni sociali e di reclutare adepti tra i profughi Rohingya, vittime del bestiale genocidio perpetrato dall’esercito birmano.
Nei campi allestiti a Cox’s Bazar, nel sud del Paese, un milione di rifugiati sopravvive grazie agli aiuti delle Nazioni Unite e delle organizzazioni umanitarie. Sono i dannati della Terra, un popolo senza patria, senza identità, senza futuro, perseguitato in Myanmar e straniero in Bangladesh. Nelle misere baracche di plastica e pali di bambù raccontano di case bruciate, villaggi bombardati e rasi al suolo, famiglie sterminate, donne stuprate, bambini fatti a pezzi davanti ai genitori, neonati gettati vivi nel fuoco. E la pulizia etnica continua.
Musubbat, 70 anni, è appena arrivata: “I soldati” racconta “hanno demolito la moschea e ucciso i 400 abitanti del distretto di Busidong. Hanno violentato mia nipote e le hanno tagliato la gola. Per salvarmi mi sono finta morta”. Per sfuggire al massacro nel villaggio di Napura, Mumtaz, 40 anni, ha nascosto i sei figli nella foresta, al riparo dai cecchini: “Siamo rimasti otto giorni senza mangiare, poi abbiamo camminato fin qui”. Ali Ahmed, 80 anni, sa che non rivedrà più il paese di Nayapara: “Morirò qui, dove almeno c’è qualcuno che pregherà sulla mia tomba”.
Ma sul campo profughi più grande del mondo, dove i trafficanti di esseri umani vanno a caccia di ragazzine da vendere ai bordelli e i medici lottano per arginare la malnutrizione e le malattie, sta per abbattersi un altro flagello: la stagione dei monsoni, l’incubo delle agenzie umanitarie.
I rifugiati hanno divelto anche le radici degli alberi per fare legna da ardere: frane, smottamenti, inondazioni e conseguenti epidemie saranno inevitabili. Fiumi di fango travolgeranno le capanne, trascinando a valle i cadaveri sepolti nei cimiteri in collina, distruggendo le latrine e contaminando la falda acquifera. “Sarà una catastrofe” prevedono i responsabili di Medici senza frontiere, che hanno attrezzato un ospedale in grado di resistere alla furia degli elementi. “E nell’eventualità di un ciclone dovremo fronteggiare un’emergenza che non ha precedenti”. I terrificanti venti delle tempeste tropicali rischiano di spazzar via le baracche, i centri sanitari, le scuole, le moschee, gli orfanotrofi, le mense, i magazzini alimentari, trasformando in una trappola mortale la nuova patria dello sventurato popolo Rohingya.
Amina sta scavando un fossato intorno alla sua casa, un tugurio di stracci nell’oceano di catapecchie abbarbicate al fianco di un’altura, e ogni tanto alza gli occhi al cielo: “Le piogge” dice “cadranno presto. Che Allah ci protegga!”